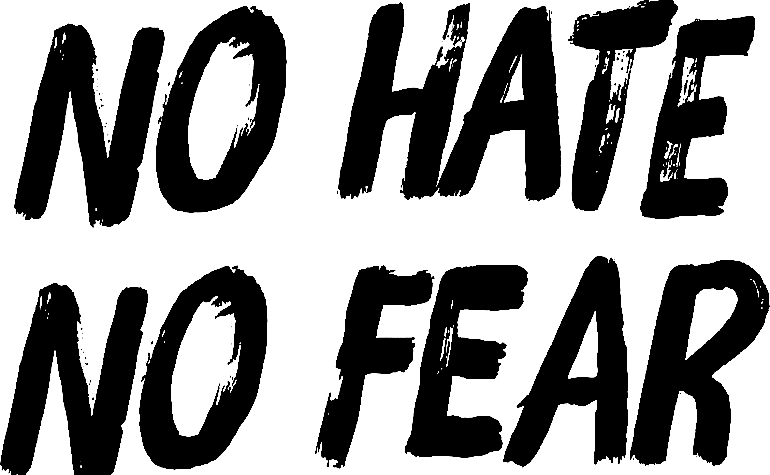di Luciano Scalettari
tratto da Gariwo
L’ultimo episodio è di pochi giorni fa, giovedì 23 febbraio: su Facebook compare un video dove si vedono un paio di dipendenti di una catena di supermercati che “immortalano”, filmando col cellulare, la loro impresa. Hanno scovato due donne (che vengono subito definite rom) che frugano fra le cose di scarto, che stanno per essere gettate perché scadute o rovinate. Le chiudono dentro questa gabbia di metallo e, mentre le donne urlano a squarciagola, sghignazzano e le deridono.
È solo l’ultimo caso di decine, centinaia che avvengono in Rete. Naturalmente il video diventa immediatamente virale: condivisioni, commenti, rilanci. C’è chi condanna e si scandalizza, chi dice il solito “io non sono razzista, però…”, chi rincara la dose (“Io mollerei anche i cani in quella gabbia”, “getterei loro le noccioline”, e via di questo passo), c’è chi arriva a invocare i campi di sterminio, con tanto di foto di Hitler. Una cloaca d’odio, di razzismo, di pregiudizi. Non è finita. I mezzi d’informazione riprendono la notizia, l’amplificano, ne discutono, chi scandalizzandosi, chi definendolo “solo un gioco, mica le hanno tenute dentro ore”). Ognuno a modo suo, con tutte le sfumature fra il plauso e la condanna sdegnata. Ma intanto fa notizia, quindi… vai con le zingare in gabbia.
Davvero un episodio emblematico. “Racconta” tutti gli elementi della deriva in atto. Che non è nulla di diverso dai muri dell’Ungheria o dai decreti antiislamici che vorrebbe Trump. La differenza è soltanto che si tratta di muri, di affondamenti, di uccisioni, di lapidazioni fatti di parole.
Sono meno gravi se sono fatti di parole? Vale la pena di ricordare come cominciò la preparazione remota del genocidio ruandese del 1994 (ma anche questo vale come esempio, purtroppo non è l’unico). Cominciò quattro anni prima, nel 1990. Cominciò con un preciso e articolato piano di comunicazione. Allora, in Africa, non si usava la Rete, per “colonizzare” il pensiero dell’opinione pubblica: era la radio il mezzo che tutti usavano, e i giornali di carta quello della fascia più ricca, culturalmente più attrezzata, politicamente più impegnata. Prima delle azioni il genocidio fu messo in atto con le parole. Nacquero addirittura giornali e radio “dedicati” per preparare l’opinione pubblica ad accettare l’idea e poi a partecipare all’azione concreta dello sterminio sistematico.
Si potrebbe dire: ma l’Italia e l’Europa del XXI secolo non è il Ruanda di quegli anni. Davvero? Ne siamo così sicuri? Se lo siamo significa che già abbiamo fortemente alzato la soglia dell’accettabilità delle parole d’odio, razziste e xenofobe. I 30 mila morti del cimitero-Mediterraneo fanno indignare e reagire una minoranza dell’opinione pubblica. E un’altra minoranza non ne è affatto dispiaciuta. Nel mezzo ci sta quella maggioranza che non plaude ma non si scandalizza. L’ha accettato, appunto.
Vogliamo andare oltre? Quanti alzano un ditino per dire che la recente distinzione “linguistica” fra migranti economici e migranti di guerra è una tragica ipocrisia per renderci accettabile l’idea che si possano cacciare indietro poveri, profughi ambientali, transfughi che scappano dalle dittature, persone che semplicemente provengono da Paesi che impediscono loro una vita dignitosa e una legittima possibilità di costruirsi un futuro migliore? Anche in questo caso l’operazione è tutta linguistica: distinguo fra migranti di serie A e di serie B; appiccico a questi ultimi un’etichetta nuova che li “ripulisce” da tutte quelle terminologie che darebbero loro un “diritto” – legale e/o morale – all’accoglienza. Opero infine un abile gioco di prestigio: scompare il concetto di diritto umano a migrare e, soprattutto, a restare nel proprio Paese (diritto negato a tutti coloro che sono costretti a lasciarlo per qualsivoglia ragione), e lo sostituisco con “migrante economico”, ossia migrante-che-potrebbe-fare-a-meno-di-migrare-ma-sceglie-di-farlo-lo-stesso. Ecco, il gioco è fatto. L’opinione pubblica è pronta a dire: “Be’, allora è affar suo”.
Chi ha la responsabilità di questa deriva? Chi consente e accentua, oggi, questo slittamento verso l’esclusione, la chiusura, l’intolleranza, fino alla xenofobia e al razzismo. E, domani, fino a dove?
Credo vi siano tre categorie, su cui pesa tale responsabilità. Assai di più di tutti gli altri. Politici, opinion maker e giornalisti. I primi due gruppi hanno la sola e semplice responsabilità delle opinioni che esprimono, delle parole che utilizzano, dei temi che vogliono cavalcare. A questo riguardo, la domanda è: il diritto d’espressione e di parola è illimitato? Si può “dire quello che si vuole”, come sostiene qualcuno? E ancora: ogni opinione deve essere accettata, riferita, discussa? Credo di no. Il patrimonio di valori e di principi che – quantomeno in Italia, in Europa e nei Paesi che hanno consolidate democrazie – è stato costruito lungo la storia, spesso a costo di guerre, sangue e vittime, consente di stabilire una linea di demarcazione. Chi inneggia o si richiama oppure plaude a uomini e ideologie di violenza, di odio, di supremazia di una razza o di una religione sull’altra, di un orientamento sessuale su un altro, di un Paese su un altro, di un sistema economico su un altro non ha diritto di parola. Lo perde nel momento in cui si pone fuori da quel ricco e prezioso patrimonio di valori e di principi che abbiamo faticosamente costruito.
E qui entra in gioco la terza categoria: quella dei giornalisti e di tutti coloro che operano nella comunicazione. Di fronte alla “parola che uccide, che discrimina, che violenta” il giornalista toglie la parola. Non rilancia, non cita, non intervista. Chi si pone fuori da quel (peraltro ampio) recinto che tutela i diritti della persona e dei popoli perde il diritto di parlare alla comunità che in quel patrimonio si riconosce.
Anche gli operatori dell’informazione si sono costruiti il proprio apparato ideologico e deontologico per giustificare qualunque scelta: la cosiddetta terzietà del giornalista, il suo essere puro megafono da porre davanti a chiunque abbia qualcosa da dire “di interesse pubblico”, il diritto assoluto alla libertà di espressione e di opinione. Altro grande gioco di prestigio, altra mistificazione: il diritto inviolabile ad avere le proprie opinioni e convinzioni e a non essere per questo perseguitato e limitato nella libertà è diventato, invece, il diritto a esprimerla (ecco i social network che oramai ospitano qualunque nefandezza) e il diritto alla diffusione mediatica da parte dei mezzi d’informazione.
No, questi ultimi non sono diritti. E non lo sono per il semplice motivo che quel diritto viola un diritto più grande: quello di non essere “uccisi” da quella parola o da quella opinione.
Infine, credo che ci sia un dovere, da parte di giornalisti e operatori dell’informazione, perlomeno dal punto di vista deontologico e morale: quello di dare la parola a chi difende e sta dalla parte di quel patrimonio di diritti fondamentali della persona che è l’unica vera e solida base della convivenza civile.
Credo che l’intera categoria degli operatori dell’informazione abbia bisogno di riflettere e di discutere su queste questioni.
In gioco potrebbe non esserci necessariamente un genocidio, ma la dignità e spesso la vita di tante persone certamente sì.
tratto da Gariwo
L’ultimo episodio è di pochi giorni fa, giovedì 23 febbraio: su Facebook compare un video dove si vedono un paio di dipendenti di una catena di supermercati che “immortalano”, filmando col cellulare, la loro impresa. Hanno scovato due donne (che vengono subito definite rom) che frugano fra le cose di scarto, che stanno per essere gettate perché scadute o rovinate. Le chiudono dentro questa gabbia di metallo e, mentre le donne urlano a squarciagola, sghignazzano e le deridono.
È solo l’ultimo caso di decine, centinaia che avvengono in Rete. Naturalmente il video diventa immediatamente virale: condivisioni, commenti, rilanci. C’è chi condanna e si scandalizza, chi dice il solito “io non sono razzista, però…”, chi rincara la dose (“Io mollerei anche i cani in quella gabbia”, “getterei loro le noccioline”, e via di questo passo), c’è chi arriva a invocare i campi di sterminio, con tanto di foto di Hitler. Una cloaca d’odio, di razzismo, di pregiudizi. Non è finita. I mezzi d’informazione riprendono la notizia, l’amplificano, ne discutono, chi scandalizzandosi, chi definendolo “solo un gioco, mica le hanno tenute dentro ore”). Ognuno a modo suo, con tutte le sfumature fra il plauso e la condanna sdegnata. Ma intanto fa notizia, quindi… vai con le zingare in gabbia.
Davvero un episodio emblematico. “Racconta” tutti gli elementi della deriva in atto. Che non è nulla di diverso dai muri dell’Ungheria o dai decreti antiislamici che vorrebbe Trump. La differenza è soltanto che si tratta di muri, di affondamenti, di uccisioni, di lapidazioni fatti di parole.
Sono meno gravi se sono fatti di parole? Vale la pena di ricordare come cominciò la preparazione remota del genocidio ruandese del 1994 (ma anche questo vale come esempio, purtroppo non è l’unico). Cominciò quattro anni prima, nel 1990. Cominciò con un preciso e articolato piano di comunicazione. Allora, in Africa, non si usava la Rete, per “colonizzare” il pensiero dell’opinione pubblica: era la radio il mezzo che tutti usavano, e i giornali di carta quello della fascia più ricca, culturalmente più attrezzata, politicamente più impegnata. Prima delle azioni il genocidio fu messo in atto con le parole. Nacquero addirittura giornali e radio “dedicati” per preparare l’opinione pubblica ad accettare l’idea e poi a partecipare all’azione concreta dello sterminio sistematico.
Si potrebbe dire: ma l’Italia e l’Europa del XXI secolo non è il Ruanda di quegli anni. Davvero? Ne siamo così sicuri? Se lo siamo significa che già abbiamo fortemente alzato la soglia dell’accettabilità delle parole d’odio, razziste e xenofobe. I 30 mila morti del cimitero-Mediterraneo fanno indignare e reagire una minoranza dell’opinione pubblica. E un’altra minoranza non ne è affatto dispiaciuta. Nel mezzo ci sta quella maggioranza che non plaude ma non si scandalizza. L’ha accettato, appunto.
Vogliamo andare oltre? Quanti alzano un ditino per dire che la recente distinzione “linguistica” fra migranti economici e migranti di guerra è una tragica ipocrisia per renderci accettabile l’idea che si possano cacciare indietro poveri, profughi ambientali, transfughi che scappano dalle dittature, persone che semplicemente provengono da Paesi che impediscono loro una vita dignitosa e una legittima possibilità di costruirsi un futuro migliore? Anche in questo caso l’operazione è tutta linguistica: distinguo fra migranti di serie A e di serie B; appiccico a questi ultimi un’etichetta nuova che li “ripulisce” da tutte quelle terminologie che darebbero loro un “diritto” – legale e/o morale – all’accoglienza. Opero infine un abile gioco di prestigio: scompare il concetto di diritto umano a migrare e, soprattutto, a restare nel proprio Paese (diritto negato a tutti coloro che sono costretti a lasciarlo per qualsivoglia ragione), e lo sostituisco con “migrante economico”, ossia migrante-che-potrebbe-fare-a-meno-di-migrare-ma-sceglie-di-farlo-lo-stesso. Ecco, il gioco è fatto. L’opinione pubblica è pronta a dire: “Be’, allora è affar suo”.
Chi ha la responsabilità di questa deriva? Chi consente e accentua, oggi, questo slittamento verso l’esclusione, la chiusura, l’intolleranza, fino alla xenofobia e al razzismo. E, domani, fino a dove?
Credo vi siano tre categorie, su cui pesa tale responsabilità. Assai di più di tutti gli altri. Politici, opinion maker e giornalisti. I primi due gruppi hanno la sola e semplice responsabilità delle opinioni che esprimono, delle parole che utilizzano, dei temi che vogliono cavalcare. A questo riguardo, la domanda è: il diritto d’espressione e di parola è illimitato? Si può “dire quello che si vuole”, come sostiene qualcuno? E ancora: ogni opinione deve essere accettata, riferita, discussa? Credo di no. Il patrimonio di valori e di principi che – quantomeno in Italia, in Europa e nei Paesi che hanno consolidate democrazie – è stato costruito lungo la storia, spesso a costo di guerre, sangue e vittime, consente di stabilire una linea di demarcazione. Chi inneggia o si richiama oppure plaude a uomini e ideologie di violenza, di odio, di supremazia di una razza o di una religione sull’altra, di un orientamento sessuale su un altro, di un Paese su un altro, di un sistema economico su un altro non ha diritto di parola. Lo perde nel momento in cui si pone fuori da quel ricco e prezioso patrimonio di valori e di principi che abbiamo faticosamente costruito.
E qui entra in gioco la terza categoria: quella dei giornalisti e di tutti coloro che operano nella comunicazione. Di fronte alla “parola che uccide, che discrimina, che violenta” il giornalista toglie la parola. Non rilancia, non cita, non intervista. Chi si pone fuori da quel (peraltro ampio) recinto che tutela i diritti della persona e dei popoli perde il diritto di parlare alla comunità che in quel patrimonio si riconosce.
Anche gli operatori dell’informazione si sono costruiti il proprio apparato ideologico e deontologico per giustificare qualunque scelta: la cosiddetta terzietà del giornalista, il suo essere puro megafono da porre davanti a chiunque abbia qualcosa da dire “di interesse pubblico”, il diritto assoluto alla libertà di espressione e di opinione. Altro grande gioco di prestigio, altra mistificazione: il diritto inviolabile ad avere le proprie opinioni e convinzioni e a non essere per questo perseguitato e limitato nella libertà è diventato, invece, il diritto a esprimerla (ecco i social network che oramai ospitano qualunque nefandezza) e il diritto alla diffusione mediatica da parte dei mezzi d’informazione.
No, questi ultimi non sono diritti. E non lo sono per il semplice motivo che quel diritto viola un diritto più grande: quello di non essere “uccisi” da quella parola o da quella opinione.
Infine, credo che ci sia un dovere, da parte di giornalisti e operatori dell’informazione, perlomeno dal punto di vista deontologico e morale: quello di dare la parola a chi difende e sta dalla parte di quel patrimonio di diritti fondamentali della persona che è l’unica vera e solida base della convivenza civile.
Credo che l’intera categoria degli operatori dell’informazione abbia bisogno di riflettere e di discutere su queste questioni.
In gioco potrebbe non esserci necessariamente un genocidio, ma la dignità e spesso la vita di tante persone certamente sì.